 Signori, dopo attenta considerazione (o supposta tale) a distanza di otto anni e 189 post dal lancio del blog Neuro@ntropologia, sentiamo l´esigenza di fermarci un attimo. Questo blog ha voluto, in tutti questi anni, proporre temi a cavallo tra neuroscience e antropologia, con una prospettiva multidisciplinare e una chiara apertura al dibattito. Abbiamo raccontato di menti estese, di fossili, di neuroanatomie, di crani, di archeologia cognitiva, di epistemologia, di scimmie e di Neandertaliani. Siamo riusciti a intrattenervi e a intrattenerci con dati e con speculazioni, con stimoli e con provocazioni. Tutto questo rimane, per il momento, nelle pagine di questo blog, nei suoi testi e nei suoi commenti, disponibile ancora e sempre tra le braccia senza tempo della Rete. Nel frattempo, noi due autori ci prendiamo appunto una pausa, con alcune note di chiusura personali. A seguire.”
Signori, dopo attenta considerazione (o supposta tale) a distanza di otto anni e 189 post dal lancio del blog Neuro@ntropologia, sentiamo l´esigenza di fermarci un attimo. Questo blog ha voluto, in tutti questi anni, proporre temi a cavallo tra neuroscience e antropologia, con una prospettiva multidisciplinare e una chiara apertura al dibattito. Abbiamo raccontato di menti estese, di fossili, di neuroanatomie, di crani, di archeologia cognitiva, di epistemologia, di scimmie e di Neandertaliani. Siamo riusciti a intrattenervi e a intrattenerci con dati e con speculazioni, con stimoli e con provocazioni. Tutto questo rimane, per il momento, nelle pagine di questo blog, nei suoi testi e nei suoi commenti, disponibile ancora e sempre tra le braccia senza tempo della Rete. Nel frattempo, noi due autori ci prendiamo appunto una pausa, con alcune note di chiusura personali. A seguire.”
Emiliano Bruner:
Questo blog ha rappresentato senza dubbio un inizio. In questi otto anni grazie allo stimolo di questa iniziativa ho poi scritto e coordinato dieci blog differenti, mischiando neuroscienza, antropologia, zoologia, museologia, evoluzione, fotografia, società, musica, e un pò di tango. L’obiettivo di tutto questo scrivere è stato dare un esempio alternativo alla superficialità delle reti sociali, alla divulgazione economica da baraccone, alla scienza spiccia dell’intrattenimento da salotto, agli scialbori delle cricche accademiche e dei loro compagni di merende, e perchè no anche alla brutta grafica che appesta la rete per mancanza di criterio, di capacità tecnica, e di soprattutto di impegno. A volte mi sa che ci sono pure riuscito. Tutto questo in un contesto, quello dell’informazione in internet, che soffre dei soliti mali di sempre: dietro ad una impercettibile percentuale di persone che attivamente contribuiscono allo strumento e alle sue applicazioni, miliardi di usuari senza prospettiva nè criterio abusano di una tecnologia e di una cultura che non capiscono e che non hanno la minima intenzione di capire, generando un mercato florido e lobotomizzante che orienta inevitabilmente gli sviluppi dello strumento stesso in direzioni illogiche e totalmente distrofiche. Come nella epopea della Fondazione di Asimov, gli invisibili sono sempre lí a dare qualche colpetto per cercare di raddrizzare il cammino, ma più di tanto non si può fare, e non sarebbe manco giusto farlo: tra i diritti del genere umano vi è probabilmente anche quello alla stupidità e all’insuccesso. Otto anni di blogging, a parte aver rappresentato una ottima palestra dialettica e divulgativa, nel mio caso hanno costantemente testimoniato l’evolversi di una storia individuale, che ha condotto ad un messaggio crudo ma necessario: la vita è un cammino solitario. La scienza, la musica, il lavoro, le relazioni sociali, fa tutto parte di un percorso relativamente breve che uno alla fine fa da solo. Può sembrare un messaggio allo stesso tempo scontato e troppo duro, ma non credo convenga vivere una esistenza nella speranza di scoprire che le cose siano meglio di quel che sembrano e che da sempre sono. Come statistico, non credo nel concetto di speranza, e la vedo come la vedeva Monicelli, come lo strumento che usano più meno coscientemente per poterti fregare ogni giorno e il giorno dopo. Ma anche se volessi perdermi nell’attesa, nel mentre cercherei di non rimanere senza far nulla. Quando ti accorgi che in autostrada vai nella direzione opposta, non importa se ti stai sbagliando tu o si stanno sbagliando tutti gli altri: sia come sia, meglio accostare e scendere dall’auto. Qualcuno si intigna e alla fine si schianta. Qualcuno gira la macchina e, a sguardo basso e depressione incipiente, cambia direzione. Io ho deciso di abbandonare le grandi strade e mettermi per un sentiero laterale, poco battuto, senza fretta, godendo del paesaggio, e ricordando che quel che conta non è la meta, ma il cammino. In questo cammino si incontra poca gente, ma di solito è gente interessante. Internet, il sistema nervoso di Gaia, rende questi cammini indipendenti dal tempo e dallo spazio. Ti incontri con persone che vivono da altre parti, o addirittura che hanno vissuto in altri tempi. Senza che nessuno debba decidere per gli altri, senza coercizioni o forzature, la selezione è interna, e soprattutto spontanea. Chi sale su un carro e chi no. Ognuno può decidere, e ognuno ha il diritto di rinunciare.
Otto anni fa uno studente poco ortodosso e decisamente polemico, Duilio Garofoli, mi propose di metterci a scrivere in internet. Ci siamo fatti insieme otto anni di cammino divulgativo, accademico, e personale. Non so se ci sarei caduto comunque nella rete della divulgazione online, ma di fatto è stato lui che mi ha dato la mano per salire a bordo, e quella mano ha fatto la differenza. Nel mio blog Paleoneurology continuerò a pubblicare novità puntuali sul fronte della neuroanatomia evolutiva. Probabilmente continueró a scrivere di tanto in tanto di musica e di società, a coordinare qualche blog di gruppo o istutuzionali, e a promuovere risorse online. Ma sul fronte della divulgazione scientifica per il momento mi concentreró su due progetti principali, due occasioni importanti per iniziare una seconda fase, dopo quelle iniziata otto anni fa. Qualche mese fa ho iniziato il blog Antropológica Mente su “Investigación y Ciencia”, la versione in spagnolo di Scientific American (in Italia, Le Scienze). E questo mese inizio una collaborazione con Jot Down, la principale rivista culturale digitale spagnola, coordinata con la piattaforma blog del periodico “El País”. Opportunità di portare il carro lungo sentieri interessanti, e responsabilità di farlo nel migliore dei modi. Stiamo a vedere.
Emiliano Bruner
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
Paseo Sierra de Atapuerca 3, 09002 Burgos (España)
web: http://paleoneurology.wordpress.com/
***
Duilio Garofoli:
L´idea alla base di questo blog, per quanto mi riguarda, consisteva nell´invitare persone preparate, indipendentemente da titoli o posizioni accademiche varie, o semplicemente curiose, a confrontarsi con noi nei vari ambiti multidisciplinari che abbiamo toccato. Occasionalmente, questo esperimento é riuscito, e siamo riusciti a costruire, con un numero limitato di lettori, alcuni interessanti scambi che hanno aiutato a sviluppare mutualmente (o almeno spero) la nostra conoscenza. Ahimé, non si puó negare che questi scambi siano stati molto limitati nel tempo. Forse si potrebbe dire che gli argomenti trattati siano stati troppo settoriali per attirare l´attenzione del grande pubblico. Tuttavia, sembra difficile pensare che tra scienze cognitive, antropologia, archeologia, filosofia, etc., non siamo riusciti ad attirare nemmeno l´attenzione (o meglio la partecipazione) di una nicchia di persone a cui il blog era rivolto. L´aspetto piú amaro di una esperienza che tutto sommato ritengo positiva, sta nella frase che molti colleghi mi hanno rivolto, quando invitati a confrontarsi con noi nel blog: “Preferisco limitarmi a leggere quello che scrivete, senza replicare, perché ho paura di dire sciocchezze che poi rimangono lí, in evidenza”. Ora, mi viene da pensare, é possibile che i “datori di lavoro” siano una massa di mefistofelici individui, atti a scandagliare la rete h24 a caccia delle dichiarazioni fallaci scritte su un blog, piuttosto che valutare il reale valore reale di un candidato? Certo é che ormai uno deve essere pronto a tutto, ma posto che la blogosfera garantisce un parziale anonimato grazie ai nickname, proteggendo cosí anche i piú pavidi individui da eventuali svarioni, lo spauracchio della figura grama come scusa per la non-partecipazione lascia il tempo che trova. Personalmente sono convinto che non ci sia grande interesse, almeno nel nostro Paese, riguardo allo sviluppo di argomenti elevati mediante blog o social media. Non credo la responsabilitá sia da attribuirsi all´essenza stessa di questi nuovi media. In ambito politico, infatti, non mancano gli impavidi. La rete sembra infatti ricolma di commenti, analisi, argomenti filosofici (spesso da bar, sfortunamente) e dati (spesso decontestualizzati, purtroppo), che vengono pubblicati senza paura in lungo ed in largo. In questo caso, tuttavia, é la logica del “noi contro loro” a spingere le persone a ricercare sempre nuovi argomenti da brandire come clave contro i loro oppositori verbali, trasformando i social media in un ring, piuttosto che renderli un´occasione per capire meglio come stanno le cose. Anche in questo caso, tuttavia, il livello di analisi non é quasi mai alimentato da un desiderio di conoscenza fine a se stesso, ma si ferma spesso laddove é sufficiente per vincere lo scontro dialettico. Tolta questa base emotiva, eliminato il pomo della discordia, l´interesse per le dinamiche profonde della realtá svanisce e resta una generale assenza di visione machiana. Quindi, non mi ritroverete a scrivere su alcun blog, piattaforma o sito aperto al pubblico, ma resteró disponibile per comunicazioni private tramite la mia pagina personale (link a breve). Anche io lascio dunque la via maestra, ma passo alla montagna, e medito alla maniera dell´eremita, tenendo una finestra aperta sul mondo. Non sia mai che, una volta riaperti gli occhi ed interrotta la meditazione, io mi venga a trovare in compagnia di altri eremiti, incluso un professore tatuato di nome Emiliano Bruner.
Duilio Garofoli
Cognitive Archaeology Unit
Institute of Natural Science in Archaeology
Eberhard Karls University of Tübingen
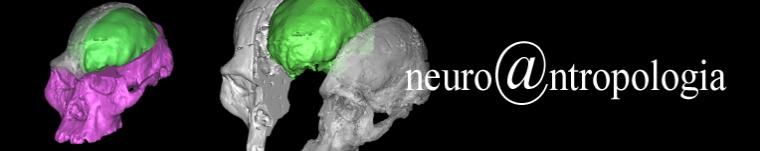
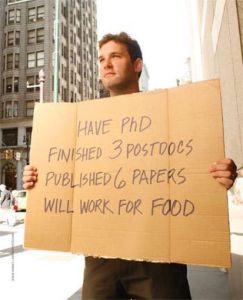

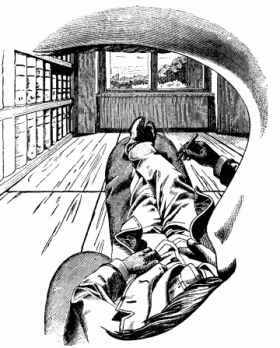

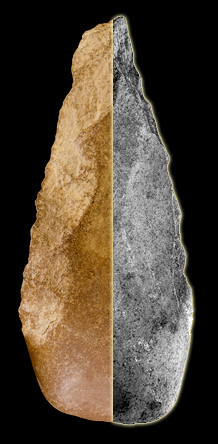



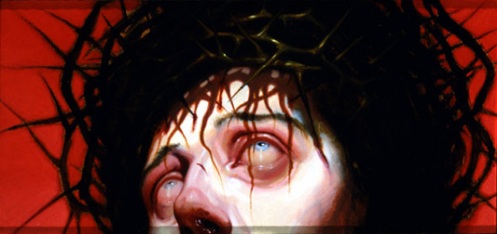

Commenti